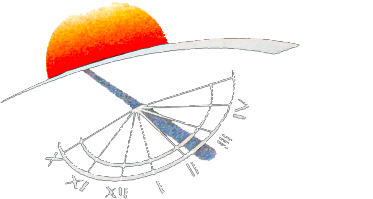[vc_row][vc_column][vc_column_text]XX SETTEMBRE
di Bruno Segre (intervento pubblico in occasione della commemorazione rivolese in pari data del 2010)
A differenza di altri importanti Stati d’Europa, come la Francia e la Gran Bretagna, che da secoli avevano raggiunto l’unità nazionale, l’Italia del Risorgimento era ancora divisa nel 1860 in sette Stati. Per unificarla bisognava fondere sette codici, sette monete, sette sistemi doganali. Diventò evidente che per unificare il Paese, popolato da 25 milioni di abitanti (nell’80% analfabeti o semianalfabeti) occorreva, dopo i plebisciti, estendere a tutto il territorio le regole piemontesi, compreso lo Statuto del regno concesso nel 1848.
Il suggello dell’unità nazionale era Roma capitale d’Italia, ma la città era da 1000 anni capitale dello Stato della Chiesa e godeva della protezione della Francia.
In un memorabile discorso del 25 marzo 1861 alla Camera dei deputati Cavour affermò: “Perché noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere, di insistere, perché Roma sia riunita all’Italia? Perché senza Roma capitale d’Italia, l’Italia non si può costituire … In Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città che non abbia nessuna o pochissime memorie municipali; tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari ad oggi, è storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto, profondamente convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla Nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza appello al patriottismo di tutti i cittadini d’Italia e dei rappresentanti delle più illustri sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all’Europa: la necessità d’aver Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall’intera nazione”.
A sua volta Mazzini aveva proclamato: “Roma era ed è tuttavia, malgrado le vergogne dell’oggi, il Tempio dell’Umanità. Da Roma uscirà, quando che sia, la trasformazione religiosa che darà, per la terza volta, unità morale all’Europa”. Garibaldi aveva esclamato: “Roma! La Roma dell’idea rigeneratrice d’un gran popolo!”.
I rivoluzionari nel 1849, dopo la fuga del Papa, avevano creato a Roma la Repubblica e l’avevano difesa valorosamente contro le truppe straniere inviate da Luigi Napoleone Bonaparte, nipote dell’imperatore, alleato del Pontefice. Nonostante i sacrifici dei rivoluzionari – morirono combattendo Luciano Manara, Enrico Dandolo, Goffredo Mameli, Emilio Morosini e tanti altri – la Repubblica Romana cadde, ma l’idea del suo riscatto proseguì. Mazzini era contrario ad un’azione armata, che doveva essere preceduta dal progresso dell’idea repubblicana nel Paese. Garibaldi invece raccolse i suoi volontari e tentò dalla Sicilia di muovere su Roma. Il suo grido “Roma o morte!”accompagnò la riscossa, ma il governo sabaudo, per non urtarsi con Napoleone 111 mandò il colonnello Pallavicini di Priola a bloccare sull’Aspromonte Garibaldi, che fu ferito ad un piede.
Dalle armi si passò alla diplomazia. Nel settembre 1864 tra Italia e Francia si stipulò una Convenzione che prevedeva il ritiro della guarnigione francese da Roma entro due anni e la garanzia italiana alle frontiere dello Stato della Chiesa. In realtà la “questione romana” non veniva risolta perché, al posto dei soldati regolari francesi, vennero a presidiare Roma i volontari della “Legione Antibes”, mentre il trasferimento della capitale da Torino a Firenze era un avvicinamento all’Urbe.
Da parte sua Pio IX emanò la bolla “Sillabo”, cioè una sorta di prontuario, destinato al clero cattolico, “per orientarsi nei casi di equivoci dottrinali, di contaminazioni filosofiche, di deviazioni politiche”. Era una severa condanna d’ogni forma di liberalismo, che negava validità al progresso e alle sue conquiste, a ogni ideologia non strettamente cattolica, alla scienza, e allo Stato moderno. Il “Sillabo” destò preoccupazioni ovunque, anche in Francia dove Napoleone 111 ne proibì la divulgazione. In Italia, invece, dopo qualche perplessità, il “Sillabo” fu ammesso. Il governo dichiarò che di esso farà giustizia “il buonsenso delle popolazioni” .
Non risultando possibile alcuna intesa con il Papa, Garibaldi nel 1867 riprese le armi e giunse con le camicie rosse davanti alle mura di Roma sperando che la città insorgesse e gli aprisse le porte. Viceversa le guardie pontificie respinsero tutti gli attacchi. Lo scontro decisivo avvenne a Villa Glori, ove caddero i fratello Cairoli. Altri patrioti furono massacrati in Trastevere, come Francesco Arquati e la moglie Giuditta Tavani insieme ai loro tre figli. I muratori Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti furono catturati. Pochi giorni dopo essersi ritirato, Garibaldi fu affrontato e sconfitto a Mentana dalle truppe francesi inviate in fretta e furia da Napoleone 111 e armate di nuovissimi fucili a tiro rapido (i famosi “chassepots”).
Il ministro Ronher, parlando al Parlamento francese, affermò:
“L’Italia non si impadronirà mai di Roma. Mai la Francia tollererà questa violenza al suo onore e alla sua cattolicità”. Il presidente della Camera dei deputati italiani replicò: “Siamo unanimi a volere il compimento dell’unità nazionale. Roma. tardi o tosto. per la necessità delle cose e per la ragione dei tempi. sarà capitale d’Italia!”.
Un moto di sdegno scosse il Paese allorché il 23 novembre 1868 vennero ghigliottinati a Roma, in piazza del Popolo, i popolani Monti e Tognetti, coinvolti nel fallito tentativo d’insurrezione dell’anno precedente. Il Papa si sente sicuro, tanto da aprire i lavori del Concilio Ecumenico Vaticano che approva il dogma di fede e morale della infallibilità papale quando parla “ex-cathedra”.
Ma intanto è scoppiata la guerra tra la Prussia e la Francia. In Italia la popolazione solidarizza con la Prussia in quanto non dimentica la vicenda di Mentana. Invece Vittorio Emanuele II, memore del contributo dato nel 1859 dalla Francia all’indipendenza italiana contro gli austriaci, vorrebbe appoggiare l’esercito francese. Comunque, il governo proclama la neutralità.
Quando però Napoleone III richiede l’aiuto italiano nella guerra, il governo non esita a fargli sapere che tale aiuto può venire: ma deve essere compensato con Roma. L’imperatore, che ora più che mai ha bisogno dei cattolici francesi, replica facendo dire a un suo ministro che “la Francia non può difendere il suo onore sul Reno sacrificandolo sul Tevere”.
Poiché Vittorio Emanuele, spalleggiato dal generale Cialdini, tempesta per dare aiuto a Napoleone, il Ministro Quintino Sella gli porge alcuni telegrammi annuncianti che il generale Mac Mahon è stato sconfitto dai prussiani. Se i francesi usavano la loro nuova arma, la mitragliatrice, i prussiani impiegarono i potentissimi cannoni Krupp. Il 7 agosto giunge a Vittorio Emanuele un telegramma personale di Napoleone, che invoca soccorso. Ormai è chiaro che nulla si potrà fare, a meno che non si voglia associare l’Italia alla sconfitta. Sgomento e mortificato, il re tace.
Si è frattanto deciso di tornare alla Convenzione di settembre, In modo da permettere alla guarnigione francese in Roma di rientrare In patria per raggiungere il fronte. Il 18 agosto i francesi sono nuovamente e duramente sconfitti a Gravelotte. Il giorno dopo, l’imperatore manda in Italia il principe Girolamo Bonaparte (suo cugino, marito della principessa Clotilde di Savoia, figlia del re), a compiere un supremo tentativo: “Fate quello che volete con Roma”, pare dica Girolamo. Ma l’accoglienza che gli è riservata lo raggela. Urbano Rattazzi sintetizza, con la frase: “Mentana grida vendetta”, il sentimento di gran parte dell’opinione pubblica italiana. Si sta profilando intanto la decisiva sconfitta francese, quella che sbalzerà Napoleone III dal trono e dalla Storia.
Il 3 settembre giunge a Firenze la notizia del disastro di Sedan: inesorabilmente battuti, i francesi si sono arresi. Tra gli 85.000 prigionieri, c’è lo stesso imperatore, che ha consegnato la sua spada. Il momento di liberare Roma è arrivato. Ma il presidente del Consiglio, Lanza, ancora non sa risolversi. Quintino Sella e qualche altro ministro minacciano le dimissioni, e quindi la crisi. La sinistra mobilita la piazza, e un gruppo di suoi deputati ammonisce che ogni indugio non sarebbe altro che “delitto di lesa Nazione, e tradimento”. Mentre i primi cortei percorrono le vie della città, il lninistro decide d’occupare il territorio pontificio, ma non Roma. I soldati si fermeranno davanti alla città, e nulla faranno “se non valendosi della cooperazione dei Romani stessi”.
E’ l’ultimo tentativo di mostrare al mondo che non è l’Italia che vuole prendere Roma, ma Roma stessa che vuole unirsi all’Italia.
Le manifestazioni di piazza si fanno sempre più minacciose fino a quando s’annuncia da Parigi che è stata proclamata la Repubblica, e che Jules Faure, uno dei suoi capi, ha comunicato al ministro italiano, Nigra, come la Convenzione di settembre sia morta insieme all’Impero. A questo punto, il 7 settembre, ci si risolve ad agire. Non sarà soltanto un’operazione militare e politica: sarà una sfida all’opinione cattolica e legittimista di tutto il mondo, messa di fronte all’eliminazione del potere temporale della Chiesa.
Il 9 settembre si presenta in Vaticano il conte Ponza di San Martino, inviato personale di Vittorio Emanuele. Ha un messaggio per Pio IX. “Beatissimo Padre. con affetto di figlio. con fede di cattolico. con lealtà di Re. con animo d’italiano – scrive il sovrano (in realtà la lettera è stata redatta dal giornalista Celestino Bianchi) – m’indirizzo ancora. com’ebbi a fare altre volte. al cuore di Vostra Santità. Un turbine di pericoli minacciano l’Europa. Giovandosi della guerra, che desola il centro del Continente, il partito della rivoluzione cosmopolita cresce di baldanza e di audacia e prepara, specialmente in Italia e nelle province governate da Vostra Santità, le ultime offese alla Monarchia e al Papato … Io veggo la indeclinabile necessità. per la sicurezza dell’Italia e della Santa Sede, che le mie truppe, già poste a guardia dei confini. si inoltrino ad occupare Quelle posizioni che saranno indispensabili per la sicurezza della Vostra Santità e pel mantenimento dell’ordine … La Santità Vostra, liberando Roma dalle truppe straniere, togliendola al pericolo continuo d’essere il campo di battaglia dei partiti sovversivi, avrà dato compimento ad un’opera meravigliosa, restituita la pace alla Chiesa, mostrato all”Europa spaventata dagli orrori della guerra come si possono vincere grandi battaglie ed ottenere vittorie immortali con un atto di giustizia, con una sola parola d’affetto … ” Il re conclude: “Prego Vostra Beatitudine di volermi impartire la sua Apostolica benedizione e riprotesto alla Santità Vostra i sentimenti del mio profondo rispetto”.
La lettera suscitò lo sdegno del Pontefice, che ricevendo dopo qualche giorno l’emissario italiano esclamò: “Bella lealtà! Siete tutti un sacco di vipere, sepolcri imbiancati, mancatori di fede!”. Nella sua risposta al re, il Papa dichiarò che non era disposto a concedere nulla e tanto meno l’apostolica benedizione. Congedando Ponza di San Martino il papa affermò: “lo non sono profeta, né figlio di profeta ma vi assicuro che in Roma non entrerete!”.
Miglior profeta fu il governo italiano che affidò l’operazione militare al “Corpo d’esercito d’osservazione dell’Italia Centrale”, con quartier generale a Terni e con comandante il generale Raffaele Cadorna. A formarlo, vennero chiamate tre divisioni: l’11° (generale Cosenz), la 12° (generale Mazé de la Roche), la 13° (generale Ferrero). A queste furono aggiunte due altre divisioni, la 2° (generale Bixio) e la 9° (generale Angioletti), nonché una cospicua forza di riserva.
A ogni divisione vennero aggregati una unità di cavalleria e battaglioni di bersaglieri. Il cinquantacinquenne Cadorna è un ufficiale piemontese senza fantasia e con modesta intelligenza. Si è distinto alla battaglia di Custoza e ha represso severamente l’insurrezione di Palermo del 1866 e i moti del ’69 in Emilia contro il macinato. Cattolico convinto, si propone di agire “non solo come soldato che obbedisca, irresponsabile del fine ultimo della sua missione, ma come uomo convinto di servire a un tempo patria e religione”, persuaso, a dispetto del “Sillabo” che la perdita del potere temporale gioverà alla Chiesa.
Quando apprende che una Divisione sarebbe stata comandata da Bixio, ha un moto di sdegno e si affretta a definirlo non idoneo per il suo carattere impetuoso. Infatti Bixio aveva esclamato in Parlamento che i cardinali erano da gettarsi tutti nel Tevere. In realtà Cadorna non capisce il significato politico e morale della designazione di Bixio, che fu ferito combattendo nel 1849 a difesa della Repubblica Romana e quindi rappresenta ora la rivoluzione emancipatrice per la capitale d’Italia.
Per l’impresa militare sono impiegati 50.000 uomini che dovranno vedersela con 13.624 pontifici, dei quali 8.300 sudditi del papa, e 5.324 volontari o mercenari esteri, inquadrati negli Zuavi, nei Cacciatori e nella Legione d’Antibo.
Gli italiani passano la frontiera pontificia il lO settembre. Le divisioni destinate all’azione principale scenderanno il Tevere tenendosi sulla sua destra, e dopo averlo varcato a monte di Roma, investiranno la città in corrispondenza del tratto di mura tra le porte Pia e Salaria, nel punto più favorevole per un attacco, ove i Galli, i Goti e altri più recenti nemici entrarono in Roma.
Alle truppe del Corpo d’osservazione si sono unite frotte di giornalisti (tra loro Raffaele Sonzogno, editore ormai celebre, già comproprietario della “Gazzetta di Milano”: si porta appresso un piccolo impianto tipografico, intendendo fondare un giornale appena entrerà in Roma: lo farà, pubblicando il 21 settembre, il primo numero de “La Capitale”). Giornalisti che infastidiscono Cadorna non meno dei deputati, dei curiosi e dei vecchi cospiratori, i quali seguono i soldati, ansiosi di assistere alla liberazione di Roma. Le truppe italiane penetrano nel territorio pontificio partendo da Orvieto (divisione Bixio), Narni (divisione Ferrero), Terni (divisione Mazè de la Roche), Rieti (divisione Cosenz) e Ceprano (divisione Angioletti, l’unica che muova da sud). Mentre Bixio si dirige a Civitavecchia, che il 16 settembre alzerà senza resistenza la bandiera bianca, gli altri Corpi marciano direttamente su Roma.
Cadorna invia un suo ufficiale con un messaggio per il generalissimo nemico, Kanzler: chiedendo “!’ingresso della truppa italiana in Roma, onde occupare militarmente la città”, assicurando che “la missione delle RR. truppe è puramente conservatrice e diretta a tutelare l’ordine”, che “gli ufficiali e i sottufficiali indigeni sarebbero conservati nei loro gradi”, a differenza degli stranieri, che se ne dovranno andare.
Kanzler replica seccamente: “Ho ricevuto l’invito di lasciar entrare le truppe sotto il comando dell’Eccellenza Vostra: Sua Santità desidera di veder Roma occupata dalle proprie truppe, e non da quelle di altri sovrani. Pertanto sono risoluto di fare resistenza coi mezzi che stanno a mia disposizione, come m’impone l’onore e il dovere”.
Avanti, dunque. L’Aniene è raggiunto, e l’11° e la 12° Divisione SI schierano nella zona dei ponti Salario e Nomentano, mentre la 13° marcia per disporsi lungo la via Tiburtina. Gli zappatori del Genio stanno lavorando per riattare il ponte Salario, distrutto dai pontifici in ritirata, e campo di Cadorna il conte Arnim von Suckow, ambasciatore di Prussia presso la Santa Sede; chiede che l’attacco a Roma sia rinviato di almeno 24 ore: c’è ancora speranza di riuscire a evitare lo scontro che i militari papalini intendono assolutamente imporre, ma che il pontefice, premuto dal Corpo diplomatico, potrebbe forse evitare. Cadorna si impegna a non far fuoco, non però ad arrestare l’avanzata.
Il giorno dopo, 18, convoca i suoi generali per le ultime intese In vista dell’attacco: Cosenz muoverà su Porta Pia, e queste saranno le azioni principali. Gli attacchi che Ferrero compirà su Porta San Lorenzo e Angioletti su Porta San Giovanni, avranno una funzione diversiva. Giunge, intanto, un messaggio del conte Arnim sull’esito negativo delle trattative.
Cadorna informa il ministro della Guerra, Ricotti, che gli risponde così: “Essendo esauriti i mezzi conciliativi, il governo del Re ha deciso che le truppe operanti sotto i di Lei ordini debbano impadronirsi di forza della città di Roma, salva sempre la città leonina, lasciando a V. S. la scelta del campo e dei mezzi. Nel comunicarle questo ordine del Consiglio dei ministri, mi limito a rammentarle che le condizioni politiche richiedono più che mai prudenza, moderazione e prontezza”.
Roma è tranquilla. Si è iniziato il giorno 16 un solenne triduo, mentre gli zappatori lavorano per completare le fortificazioni. Alcune porte della città sono state murate; davanti a quelle lasciate agi bili si sono costruiti terrapieni, muniti di cannoni da campo. I pezzi di cui dispone Kanzler sono circa 160, non tutti in grado di funzionare: quelli rigati sono pochi. Buono l’armamento dei soldati, specie dei volontari e mercenari stranieri. I cappellani hanno fatto sapere che saranno disponibili tutta la notte per le confessioni.
Pio IX fa pervenire al suo generalissimo una lettera, nella quale, rilevato che “si va a consumare un gran sacrilegio e la più enorme ingiustizia, con le truppe di un Re cattolico, senza provocazione, anzi senza nemmeno l’apparenza di qualunque motivo, cinge assedio la capitale dell’Orbe cattolico”, ringrazia il generale Kanzler per la sua lealtà, raccomanda la massima disciplina ai soldati e prosegue: “In quanto poi alla durata della difesa, sono in dovere di ordinare che questa debba unicamente consistere in una protesta, atta a constatare la violenza e nulla più; cioè di aprire trattative per la resa appena aperta la breccia”.
Sono istruzioni tutt’altro che chiare. La “protesta” insomma dovrà durare fino a quando non verrà aperta una breccia, vale a dire fino a quando sarà possibile una difesa efficace. Quello che è sicuro, nelle istruzioni del papa, è soltanto l’intenzione di evitare il combattimento entro la città stessa.
La sera del 19 settembre, il papa si reca alla chiesa di San Giovanni e percorre, in ginocchio, la Scala Santa. Dalle mura, poi, osserva il campo italiano, tornando tra gli applausi della folla in Vaticano, donde non uscirà più. Gli alunni del Collegio americano gli chiedono il permesso di unirsi ai combattenti; li ringrazia, e li consiglia, piuttosto, a recarsi negli ospedali e nelle ambulanze.
Giunge di tanto in tanto qualche colpo di cannone e il crepitio dei fucili. A mezzanotte, da una casa del corso, vengono gettate alcune bombe. Le chiese sono affollate di soldati in preghiera; vi sono lunghe file, davanti ai confessionali. I soldati hanno, appesa al petto, la “Croce rossa di San Pietro”, la croce rovesciata, cioè, che forma la medaglia a ricordo della giornata di Castelfidardo – quando, esattamente dieci anni prima, gli italiani sconfissero l’esercito pontificio.
Intanto Bixio, non ricevendo ordini da Cadorna, li ha chiesti direttamente al ministro della Guerra, e ricevutili è giunto sotto la città nella notte, schierando i suoi uomini di fronte al Gianicolo, a porta San Pancrazio – proprio là dove più aspra è stata la lotta tra francesi e garibaldini nel ’49. I suoi cannoni sono i più vicini alla città leonina (la zona, cioè, dei palazzi apostolici, il cui cuore è il Vaticano) che, secondo una tassativa disposizione del governo italiano, va rispettata a ogni costo.
L’ordine era di iniziare il fuoco alle 5 e 30. Ha sparato per primo “il colpo che ha fatto sobbalzare tante migliaia di cuori dentro e fuori Roma, un colpo di cannone davvero memorabile nella Storia”, una batteria della 9° divisione; in breve, si spara ovunque e i pontifici rispondono animosamente, dalle mura e dalle fortificazioni di fronte alle porte. Sulla via Nomentana essi tengono l’avamposto di villa Patrizi, donde indirizzano un intenso fuoco di fucileria contro i cannoni della 12°. I
lO
bersaglieri del 35° battaglione vengono allora mandati all’attacco attraverso il giardino, e la villa viene conquistata; i difensori finiscono per arretrare sull’opera fortificata che guarnisce Porta Pia.
È nel tratto di mura tra questa e la porta Salaria che dovrà aprirsi una breccia: di qui entreranno in Roma i soldati di Mazè e de la Roche. Entrano in azione anche i cannoni del Corpo di riserva, guidati dal generale Giacomo Segre. Le batterie sparano da una distanza che va dai 400 ai 1000 metri dalle mura.
La resistenza è particolarmente accanita nella zona di porta San Pancrazio, dove Bixio riesce ridurre al silenzio le batterie nemiche con un fuoco intensissimo; la fucileria continua rabbiosa. I cannoni pontifici sparano dagli spalti di quel “santuario” che è la Città Leonina. Vi è qualche perdita, ufficiali e soldati protestano. Bixio, deciso a rispettare rigidamente gli ordini, impreca tra i denti, ma ribadisce che sul Vaticano non si spara. Sono, comunque, della sua Divisione le cannonate che turbano Pio IX, mentre celebra la messa, l’ultima sua messa da papa-re.
Si continua il fuoco; la fortificazione all’esterno di Porta Pia comincia a cedere, e da essa vengono ritirati i due cannoni da campo; la statua di Sant’Alessandro, che era collocata in una delle grandi nicchie laterali, è decapitata, l’altra, di Sant’Agnese, danneggiata. Sfregiata la gigantesca lapide che sovrasta la porta, danneggiate le colonne, crivellate le mura.
Sotto il bombardamento cadono massi e mattoni. Le macerie SI staccano dalle mura bersagliate. Alle ore 9.30 la breccia di Porta Pia, lunga circa 30 metri, è praticabile. La porta per Roma è aperta.
Alle lO viene issata sulla torretta di villa Patrizi la bandiera del 39° reggimento, contro la quale si scatena dalle mura un intenso fuoco di fucileria, cui fa riscontro il progressivo tacere dei cannoni italiani: la bandiera è il segnale per la sospensione del fuoco. Tocca ai fanti, ora. Le truppe sfilano correndo, sciabola in mano, escono dal giardino della villa, e coperti dal fuoco dei bersaglieri del 35° battaglione, attaccano direttamente Porta Pia. La breve carica ispira il celebre quadro del Cammarano, entrato nell’iconografia ufficiale del Risorgimento.
Il tumulto continua un po’ ovunque; nella zona di piazza Colonna risuonano, ad un tratto, due o tre colpi di fucile: la folla ondeggia, si sbanda, si riforma, comincia un selvaggio inseguimento, due fuggitivi vengono raggiunti e linciati. Una banda intona l’inno reale, la gente si abbraccia, piange, grida, impreca, applaude. In questo tumulto, il principe Marcantonio Borghese manda un suo servitore a invitare il generale Bessone, il primo generale entrato in città, ad accomodarsi nel suo palazzo. Non è soltanto il popolo, dunque, a dare il benvenuto agli italiani.
Intanto Kanzler s’è presentato a Cadorna e si discutono le condizioni di resa: tutta Roma, tranne “la parte limitata al sud dai bastioni Santo Spirito, e che comprende il monte Vaticano e Castel Sant’Angelo, costituenti la città Leonina”, sarà consegnata al re d’Italia che concede gli onori militari alla guarnigione pontificia. Le truppe straniere, sciolte, saranno rimpatriate; quelle “indigene” disarmate, conserveranno la paga, in attesa di conoscere la loro posizione futura; gli ufficiali manterranno sciabole e cavalli; si potranno prendere in considerazione “i diritti di pensione” che i soldati stranieri possono aver stipulato con il governo pontificio.
Dopo la firma della capitolazione, Roma viene interamente occupata. La gente si assiepa per le strade, con gli emigrati e i soldati piemontesi che si comportano disciplinatamente, rispettosi e sereni. Il giorno appresso, 21 settembre, i soldati dell’ormai disciolto esercito pontificio, sfilano ricevendo l’onore delle armi delle truppe italiane, secondo le condizioni della resa. Oltre a Cadorna è presente anche Bixio, sebbene non invitato.
Fiaccolate patriottiche, muri tappezzati da manifesti più o meno incendiari. Viene venduto il nuovo giornale stampato da Sonzogno, cui seguono altre testate “Il Tribuno”, “Il Colosseo”, “Il Campidoglio” destinati a una vita effimera. Edmondo De Amicis si aggira prendendo appunti per la cronaca. Vengono abbattuti stemmi pontifici anche sulle facciate delle Ambasciate straniere. La calma ritorna in pochi giorni.
Il 2 ottobre viene indetto un plebiscito con la seguente formula:
“Vogliamo la nostra unione al regno d’Italia. sotto il governo del re
Vittorio Emanuele II e dei suoi successori … “. Il risultato del plebiscito è analogo a quello di quasi tutti i plebisciti indetti: a Roma 40.785 si e soltanto 46 no. In tutto l’ex-Stato Pontificio 133.081 voti favorevoli e 1507 contrari. Una successiva legge sancisce l’unione di Roma al regno d’Italia, affermando l’inviolabilità del papa e anticipando la legge delle guarentigie.
Il mondo accetta l’annessione di Roma all’Italia senza proteste ufficiali. Anzi dai governi di Parigi e di Madrid giungono messaggi di felicitazioni.
Vittorio Emanuele, forse per non offendere il pontefice o irritare le Potenze cattoliche, tarda a venire a Roma. Quando il Tevere straripa inondando alcuni quartieri, il re si presenta inatteso nell’Urbe. “Mai più grande avvenimento – scrive Alfredo Oriani – ottenne minore attenzione”. Pochissima gente era ad attenderlo alla stazione. Quando scese di carrozza, volgendosi al Lamarmora, mormorò: “Finalment i suma”.
Alla richiesta del generale Lamarmora, luogotenente del re In Roma, di consegnare le chiavi del Quirinale, Pio IX esclamò: “Questi ladri pretendono le chiavi per aprire le porte? Le abbattano se così vogliono”. Fatto sta che per entrare nel palazzo si dovette chiamare un fabbro che con i grimaldelli aprì il portone e gli usci serrati.
L’11 novembre il papa emana l’enciclica “Respicientes” che commina la scomunica a “tutti quelli che, insigniti di qualsivoglia dignità … hanno perpetrato l’invasione, l’usurpazione di questa alma città, e parimenti i loro mandatari, fautori, adiutori, consiglieri, aderenti … “.
Pio IX non perderà alcuna occasione per ribadire di trovarsi “in tale cattività che non possiamo senza alcuna sicurezza speditamente e affatto liberamente esercitare la nostra suprema autorità pastorale”.
Il 30 giugno 1871 Roma diventerà ufficialmente capitale d’Italia, dopo che il Parlamento ha approvato la legge delle guarentigie, che assicura al papa piena libertà e sovranità nell’esercizio delle sue funzioni spirituali.
La legge consta di due titoli (I: prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede; II: relazioni dello Stato con la Chiesa) e di 19 articoli, il primo dei quali recita: “La persona del Sommo Pontefice è sacra e inviolabile”.
Il papa avrà onori sovrani, potrà tenere le guardie addette alla sua persona e alla custodia dei suoi palazzi: il Vaticano, il Laterano e la villa di Castel Gandolfo, con i terreni e le dipendenze annesse, inalienabili, esenti da tasse o da esproprio, non sarà soggetto alla legge penale italiana, e vedrà punite le ingiurie nei suoi confronti. I diplomatici accreditati presso la Santa Sede godranno di tutte le prerogative e le immunità che il diritto internazionale accorda agli agenti diplomatici; egualmente garantiti, in ogni circostanza, i partecipanti ai conclavi.
Al Pontefice è data facoltà di stabilire uffici di posta e telegrafo, da collegarsi alla rete telegrafica italiana a spese dello Stato; alla Santa Sede è assegnata una dotazione annua di lire 3.225.000.
Nella 2° parte il Regno rinuncia all’assenso per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, al giuramento al Re prestato dai vescovi. Lo Stato Pontificio non possiede alcun territorio, e tranne il papa, che ha immunità e privilegi particolari, le altre persone residenti nelle zone vaticane sono soggette alle leggi italiane.
Contro la legge delle guarentigie si schierarono politici cattolici e laici: i primi perché la ritennero insufficiente a garantire una reale libertà e indipendenza del papa; i secondi perché la considerano dannosa, e privilegiante il papa stesso. Pio IX, la respinge, perché accettandola riconoscerebbe il Regno d’Italia. Non impianterà l’ufficio telegrafico, volendo così dimostrare di non essere affatto libero di comunicare con i suoi vescovi; né riscuoterà l’assegno annuale, puntualmente pagato.
Nel 1874, a ribadire l’ostilità della Chiesa al Regno d’Italia, viene diffuso il “non expedit” con cui il Vaticano risponde ai vescovi, che chiedono istruzioni sul come comportarsi di fronte alla vita politica. “Viste le attuali circostanze, non conviene che i cattolici si impegnino”. È la conferma di quel programma “né elettori né eletti” già bandito nel
1860-61.
Ma i tempi stanno cambiando, e in Italia si moltiplicano le associazioni operaie d’ispirazione socialista. A reagire a queste fiorisce l’associazionismo cattolico: c’è un congresso cattolico a Venezia, e accanto alla Società della Gioventù Cattolica italiana, sorge l’Opera dei Congressi, che chiama i credenti a presentarsi alle elezioni amministrative, e a battersi per la Chiesa in tutti i modi possibili: uno di questi è la lotta all’istruzione elementare obbligatoria, temendo per il suo carattere laico.
Comunque nel 1876 si verifica un cambiamento politico destinato a lasciare traccia profonda nella Storia della nazione: il quindicennio della Destra, iniziato da Cavour nel 1861, è finito. Il ministero Minghetti si è dimesso e il re ha affidato ad Agostino Depretis l’incarico di formare il nuovo governo. Così la Sinistra va al potere. Muore, il 9 gennaio 1878, Vittorio Emanuele, a 58 anni: pochi giorni dopo muore Pio IX, a 86 anni. I loro successori saranno Umberto I e Leone XIII.
La nostra cronaca finisce qui. Occorre però aggiungere che la liberazione di Roma con l’unificazione dell’Italia, insieme alla vittoria prussiana contro Napoleone III, la svolta repubblicana francese, la Comune di Parigi, segnò una nuova fase storica per l’Europa. C’erano grandi vuoti da colmare; lo sviluppo economico e civile per l’intera penisola, la questione sociale, l’unità del Paese nell’allargamento delle basi dello Stato, il consolidamento della Nazione e la lotta politica In sintonia con quanto avveniva nelle democrazie occidentali, ecc.
Quasi simbolo di queste ragioni il XX Settembre diventò una festa nazionale, sinché il 12 dicembre 1930 Mussolini perorò alla Camera la soppressione di tale festa sostituendola con la festa dei Patti lateranensi firmati 1’11 febbraio 1929. Ernesto Rossi commentò che in quella circostanza fu stipulata l’alleanza fra il manganello e l’ostensorio.
La Camera con 249 voti su 278 votò la soppressione della festa nazionale del XX Settembre. Il Senato, nonostante il discorso di Carducci, approvò con 87 voti contro 28 la legge Mussolini. Tuttavia l’omaggio, quasi clandestino, del popolo romano ai piedi della Breccia continuò negli anni.
Dopo la Liberazione, l’inserimento del Concordato nell’art. 7 della Costituzione provocò una situazione imbarazzante, non salvata dalle tiepide manifestazioni (1970) con l’amenità di un altare a Porta Pia e di un discorso del prete officiante.
Tuttora esistono le due date, non più festive, del 20 settembre e dell’ 11 febbraio (che, per via del neo-Concordato del 1984 fra Craxi e Casaroli, dovrebbe semmai essere corretta in 18 febbraio).
Quando il laicismo sarà più forte e il Paese più maturo politicamente, verrà abrogato il neo-Concordato e nel calendario delle feste nazionali rimarrà soltanto la data del xx Settembre.
Il settennato del presidente Ciampi ci ha restituito come Inno nazionale quello di Mameli. Perché “stringerci a corte”, perché “essere pronti alla morte” (che Mameli e tanti altri come lui hanno subito), perché “l’Italia chiamò”? Ciò che l’inno chiamava era la costituzione della Repubblica Romana del 1849 e la liberazione dell’Italia dal potere temporale dei Papi, come poi furono per la Resistenza la liberazione dal fascismo e la nascita della Repubblica. È dunque giusto che – non più “calpesti e divisi” ma diventati un popolo libero – sventoliamo l’unica bandiera, per celebrare l’imperituro ricordo del:XX Settembre.
Bruno Segre [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]